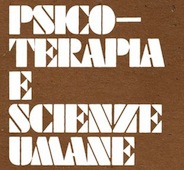Psicoterapia e Scienze Umane
Programma dei
Seminari internazionali 2023
I Seminari internazionali sono così articolati: relazione introduttiva, gruppi di discussione, discussione generale in plenaria. Obiettivo dei Seminari è fornire stimoli ed elementi di formazione permanente su temi di teoria psicoanalitica, teoria della tecnica e scienze umane. Ogni Seminario ha un coordinatore responsabile dell’organizzazione.
I Seminari Internazionali si tengono a Bologna, con inizio alle ore 14,30 e termine alle ore 19,30. E’ prevista l’assegnazione di crediti ECM. Per informazioni e/o iscrizione: comelli.dante@gmail.com
Date, relatori, titoli
18 Febbraio Bernard Golse (Paris). Pedopsichiatra-psicanalista: il più bello, e il più minacciato, mestiere del mondo
18 Marzo Antonio Semerari (Roma). Funzioni della coscienza e relazione terapeutica nella prospettiva di Pierre Janet
22 Aprile Jerome Wakefield (New York). La perdita della tristezza e la patologizzazione del dolore: stiamo patologizzando eccessivamente le normali emozioni umane?
20 Maggio Andrea Angelozzi (Padova). La persuasione in psicoterapia: dalla retorica del mondo antico alle modalità euristiche
16 Settembre Rossella Valdrè (Genova). Sulla sublimazione
21 Ottobre Paola Scalari (Venezia). Marie Langer e il corpo delle donne
18 Novembre Jean Paul Matot (Bruxelles). Elementi per una psicanalisi terrena
Presentazione del Programma 2023
Care Colleghe, cari Colleghi,
ecco il programma del prossimo anno con i sette relatori/relatrici decisamente esperti sull’argomento che ci proporranno. Del loro tema ci si può fare un’idea leggendo i riassunti, ma tutti sappiamo che la stesura di un riassunto non è sempre impresa facile. Come non è sempre facile individuare le relatrici/i relatori che fanno al caso nostro. A parte quelli/e noti nel mondo scientifico o quelli/e che sono già venuti, lasciando un bel ricordo – a volte vien voglia di sentire se hanno nuove ricerche altrettanto interessanti – ci si vale della lettura di un articolo stimolante o di un libro che ci spingono a studiare la produzione di quel/quella collega, o della conoscenza diretta o tramite un amico, o per averlo ascoltato a un congresso… insomma, i soliti modi. Riguardiamo i temi dei Seminari passati, possiamo programmare Seminari su uno stesso tema, ma affrontati da punti di vista diversi, altre volte, come per il prossimo anno, cerchiamo proprio colui che ha approfondito un particolare argomento, in questo caso la “sublimazione”, tema ricordato in un precedente seminario, ma che aveva sollevato interrogativi. Come voi sapete bene, non ci siamo mai rivolti ad un’unica “scuola”: è l’originale idea di Galli, quella della varietà. Anche se è raro che tutti piacciano a tutti (a partire dalla propria esperienza, con uno viene spontaneo parlare, domandare, obbiettare con un altro non viene in mente nulla) ogni relatore porta il suo mattoncino per l’ampliamento (o la ristrutturazione) del nostro personalissimo edificio psicoanalitico: è la “formazione permanente”. Quest’anno ho provato a suddividere le relazioni in teoriche e pratiche. Come voi sapete per alcuni la psicoanalisi non ha una vera e propria teoria generale perché manca di quelle caratteristiche che posseggono altre dottrine, come, ad es., la fisica e molte altre. Per questo ci fu la discussione se fosse o meno una scienza. Ovviamente la psicoanalisi è costruita su ipotesi che Freud spesso cambiava, seguito in questo dai suoi allievi. Qualcuno fondò una propria scuola fondata su ipotesi proprio diverse da quelle freudiane. Oggi abbiamo molte scuole. Molte delle ipotesi genericamente psicoanalitiche vengono ritenute sufficientemente verificate dalla pratica terapeutica. Un dato importante è la coerenza fra le varie ipotesi. Ma, tornando a noi, la consuetudine ci porta a parlare di teoria e io seguirò la consuetudine. La distinzione fra relazioni teoriche e relazioni pratiche mi è parsa interessante perché non è sempre facile decidere cosa è teorico (ipotetico) e cosa è pratico (clinico). Ad esempio, la relazione di Bernard Golse sembra pratica. L’autore è pediatra, pedopsichiatra, psicoanalista e afferma che il suo “è un mestiere bellissimo”. Ma nel suo riassunto c’è un punto incerto. Quando scrive che la pedopsichiatria integra i progressi delle neuroscienze “all’interno di una causalità epigenetica”: è un fatto o un’ipotesi? Lo sapremo solo leggendo la relazione o, forse, solo dal suo dire. Una relazione teorica la porta Rossella Valdrè che parlerà della sublimazione. È un concetto proposto da Freud, ma sul quale non ha mai scritto un saggio, un articolo: solo accenni qua e là. È quindi un concetto, un’ipotesi incerta. La Valdrè lo ha molto studiato e ci ha scritto un libro, “Il suo testo principale”, lo definisce. Contiamo quindi di chiarirci le idee. La relazione di Antonio Semerari, che ci parla di alcune idee di Pierre Janet è teorica, come pure tendo a definire teorica quella di Jean Paul Matot che, in questo tempo di “catastrofe ecosistemica”, propone di utilizzare in modo nuovo la psicoanalisi della quale conosciamo la capacità di far “progredire la conoscenza della vita umana”. Le altre tre relazioni sono pratiche ad iniziare da quella di Jerome Wakefield che ci riporta i risultati di una ricerca sul DSM a proposito della depressione, quella di Andrea Angelozzi sulla persuasione in psicoterapia e quella di Paola Scalari su Marie Langer e il corpo delle donne.
Buon lavoro.
Alberto Merini