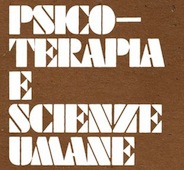Psicoterapia e Scienze Umane
Programma dei
Seminari internazionali 2018
I Seminari internazionali sono così articolati: relazione introduttiva, gruppi di discussione, discussione generale in plenaria. Obiettivo dei Seminari è fornire stimoli ed elementi di formazione permanente su temi di teoria psicoanalitica, teoria della tecnica e scienze umane. Ogni Seminario ha un coordinatore responsabile dell’organizzazione. I Seminari Internazionali si tengono a Bologna, con inizio alle ore 14,30 e termine alle ore 19,30. E’ prevista l’assegnazione di crediti ECM. Per informazioni e/o iscrizione: comelli.dante@gmail.com
Date, relatori, titoli
20 Gennaio Carlo Bonomi (Firenze). Importanza di Ferenczi nel movimento psicoanalitico oggi.
17 Febbraio Salvatore Inglese (Catanzaro). Déjà vu. Tracce di etnopsichiatria critica.
17 Marzo David Le Breton (Strasburg). Fuggire da sé per salvarsi.
14 Aprile René Kaës (Lyon). La metapsicologia oggi.
19 Maggio Roland Gori (Marseille). Sognare il mondo per poterlo trasformare.
20 Ottobre Antonio Di Ciaccia (Roma). Psicoanalisi e Politica. La cicatrice dell’evaporazione del padre al tempo d’oggi.
17 Novembre Antonino Ferro (Pavia). Sogni trasformazioni e decostruzioni.
Presentazione del Programma 2018
I “Seminari Internazionali” 2018 saranno l’occasione per sviluppare diversi temi: attualità del pensiero di Sandor Ferenczi (Carlo Bonomi), riflessioni critiche sull’etnopsichiatria (Salvatore Inglese), antropologia del disagio individuale (David Le Breton), allargamento dei confini della psicoanalisi e revisione della metapsicologia (René Kaës), il moderno disagio della civiltà (Roland Gori e Antonio Di Ciaccia), trasformazioni e decostruzioni nella psicoanalisi contemporanea (Antonino Ferro). Di seguito presentiamo alcune note come introduzione ai seminari.
Ferenczi: da oggi a ieri
Sandor Ferenczi è considerato un pioniere della psicoanalisi. Conosce Freud nel 1908 ed entra in analisi con lui. In seguito crea un sodalizio che dura quasi tutta la sua vita. I primi dissidi con Freud iniziano nel 1924 per la sua collaborazione con Otto Rank, con il quale scrive “Lo sviluppo della psicoanalisi” (pubblicato in PSU N.4 2012), per arrivare alla rottura al congresso di Wiesbaden 1932 dove Ferenczi presenta, contro il parere di Freud, l’articolo “Confusione delle lingue tra l’ adulto e il bambino: il linguaggio della tenerezza e della passione” (PSU N.3 1984 – J. Cremerius : “Riflessioni sul contributo di Ferenczi nel 1932 a Wiesbaden”). Dopo la rottura con Freud che, per alcuni storici della psicoanalisi, provoca un trauma nel movimento psicoanalitico, il nome di Sandor Ferenczi scompare dalla letteratura ufficiale psicoanalitica (con rare eccezioni) per cinquant’anni. Negli anni 1980, dopo la sofferta pubblicazione del carteggio Freud-Ferenczi e del “Diario clinico” (scritto negli ultimi mesi della sua vita) rinasce l’interesse per la sua opera grazie ad analisti come Haynal, Bonomi, Borgogno, Aron, Antonelli , Brabant, ecc. Abbiamo invitato Carlo Bonomi, che nel maggio del 2018 organizza a Firenze il 13° Congresso Internazionale Sandor Ferenczi dal titolo: “Ferenczi nel nostro tempo e un Rinascimento per la psicoanalisi “. Tra i più noti allievi di Ferenczi: Melanie Klein, Alice e Michael Balint, René Spitz, Geza Roheim, Franz Alexander, Imre Herman ….
Etnopsichiatria
L’etnopsichiatria è presente da decenni nella Rivista e nei Seminari. La sua conoscenza è sempre più necessaria in un mondo meticcio, ma anche come stimolo alla riflessione sulle nostre teorie: si veda, ad esempio, il fondamentale articolo di Paul Parin, “L’Io e i meccanismi di adattamento”, nato dai suoi soggiorni in Mali. Oltre a Parin, che trasformò la nostra conoscenza teorica dell’etnopsichiatria in qualcosa di vivo e affascinante, ricordiamo Maria Grazia Ardissone, Henry Collomb, Goldy Parin Matthey, Omar Ndoye, Piero Coppo, Tobie Nathan, Roberto Beneduce, Alberto Merini .… . Salvatore Inglese, medico, psichiatra, psicoterapeuta, ed etnopsichiatra, forte d’innumerevoli esperienze come ricercatore e come direttore del Modulo “Psichiatria transculturale e di comunità. Metodologia della ricerca” a Catanzaro e docente di Etnopsichiatria nell’Università della stessa città, approfondirà il discorso.
Antropologia del disagio individuale
Fuggire da sé per salvarsi. Può presentarsi la necessità di distaccarsi da sé anche nel ricordo, e dalla mente stessa col suo rigore. Distanziarsi da luoghi e pensieri consueti, spostare il proprio baricentro immaginario. Sfidare il mondo per trovare il nuovo e un diverso sé, per rendere familiare ciò che era estraneo. Tutto questo, magari ispirato da scoperte spirituali, può ridare sapore e grandezza alla vita, concedendo un respiro dai cicli della ripetizione e dell’abitudine, fosse anche per un solo giorno. Fuggire da sé per salvarsi. Nel racconto di Borges “La scrittura del dio”, Tzinacan, il potente mago della piramide di Qaholom, rinchiuso in una cupa torre insieme a un giaguaro, dopo aver dedicato gli anni di prigionia alla scoperta del verbo del Dio misteriosamente iscritto nelle sue macchie – una formula di quattordici parole, che, pronunciate, lo avrebbero reso libero e padrone del mondo – cionostante sceglie di morire nelle tenebre, nella nuova dignità di chi ha nel frattempo ricevuto in dono una conoscenza tale dell’universo, da dimenticare quell’altro, che era stato, che cercava il segreto, “perché adesso egli è nessuno”.
Il lavoro con i gruppi e la metapsicologia
La metapsicologia oggi. Troviamo testi di metapsicologia lungo l’intero arco dei suoi scritti ma, con i cinque saggi riuniti sotto il titolo di Metapsicologia (1915), Freud voleva costruire il modello teorico della struttura psichica e descrivere i processi psichici dal punto di vista topico, economico e dinamico (autori americani aggiunsero successivamente quelli genetico e dell’adattamento). L’impresa di costruire una modellizzazione completa si rivelò allo stesso Freud molto ardua tanto che non andò oltre i cinque saggi ricordati (ne aveva previsti dodici). Ai Seminari sono stati toccati singoli aspetti ma finora non abbiamo affrontato con occhio critico l’impalcatura concettuale nel suo complesso. Abbiamo affidato questo compito, indubbiamente non semplice, ad uno psicoanalista francese allievo di Didier Anzieu, Renè Kaës, psicoanalista dagli interessi non convenzionali: i gruppi, le istituzioni, la formazione, i fratelli… che ha pubblicato recentemente un libro sulla Metapsicologia.
Il moderno disagio della civiltà
Nel primo editoriale (1967) della Rivista “Psicoterapia e Scienze Umane” troviamo enunciate le linee del progetto culturale e formativo della rivista e quest’affermazione: “La conoscenza psicoterapeutica impone la partecipazione attiva alla realtà da costruire e non ha spazio per la fuga nel tecnicismo”. Nello spirito di quel progetto anche nel programma 2018 dei Seminari Internazionali di Psicoterapia e Scienze Umane si ripropone, con le relazioni di due psicoanalisti, il tema del “Disagio della Civiltà”: Sognare il mondo per poterlo trasformare (Roland Gori); Psicoanalisi e politica. Il malessere della civiltà (Antonio Di Ciaccia). Lo psicoanalista incontra questa dimensione nella propria esperienza in modo contingente e singolare. Affrontano il tema della Civiltà anche sociologi, antropologi, psicologi sociali, storici e filosofi ma con strumenti specifici e differenti. Alcuni si sono avvalsi anche di spunti provenienti dalle teorie freudiane. Dopo il 1920 nei suoi cosiddetti scritti sociali, Freud attribuisce al “sociale” una funzione strutturante dell’apparato psichico (attraverso il Super Io, l’ideale dell’Io e l’Io ideale), e nello stesso tempo riconosce nel sociale le potenti vestigia del funzionamento psichico (L’avvenire di un’illusione (1927), Il disagio della civiltà (1929), L’uomo Mosè e la religione monoteista (1932)). Non vi è alcuna “liberazione” possibile né dal pulsionale né dal sociale. Le nevrosi più ricorrenti non sono più quella ossessiva o quella isterica, ma il disagio della nostra civiltà, in cui la libertà appare un obbligo (!), si manifesta in altre forme: gli attacchi di panico, i disturbi del comportamento alimentare, l’autolesionismo, le dipendenze patologiche, le depressioni atipiche, i disturbi della personalità, i cosiddetti hikikomori, il cyberbullismo. I sintomi sono la vetrina della civiltà, ma non c’è civiltà senza la propria vetrina. La tesi di Freud (1927) è che la civiltà abbia due funzioni: proteggere gli umani dalla potenza della natura e regolare le relazioni tra di essi (punto da cui parte anche E. Jacques, 1951). Da questa prospettiva xenofobie e separatismi appaiono una sorta di opposizione, acritica, nei confronti di quello che Gori, nel suo libro La dignità di pensare (Alpes, 2015), chiama le forme del totalitarismo del XXI secolo ovvero: l’omogeneizzazione delle culture, la standardizzazione e l’impoverimento linguistico a favore della lingua di Wall Street. Assistiamo alla distruzione sistematica della parola creatrice in favore della parola come semplice tecnica di informazione.
Ancora metapsicologia. E clinica
Trasformazioni e decostruzioni. Antonino Ferro fa parte della cosiddetta corrente post-bioniana. Per lui Bion ci ha dato una metapsicologia completamente nuova espressa dal concetto di ” pensiero onirico della veglia”. Ferro ha congiunto il concetto di pensiero onirico della veglia con quello di campo analitico dei Baranger: “campo ferriano”. La teoria postula che tra il paziente e l’analista s’istituisce un campo di forze invisibili che influenzano potentemente la loro interazione. Il campo psichico deriva dall’incrocio delle reciproche identificazioni introiettive e proiettive.
Nota a margine.
Confronto tra posizioni divergenti: Antonino Ferro e René Kaës. In quali circostanze cliniche ha senso parlare di psicoanalisi? Sembra che due dei relatori invitati ai Seminari Internazionali 2018, abbiano posizioni molto diverse, anzi divergenti a proposito delle circostanze cliniche proprie della psicoanalisi. Antonino Ferro sostiene che “… per esservi un’analisi ci devono essere due persone e un setting. Credo che le cose minimali necessarie siano proprio queste: un analista, un paziente e un setting.” René Kaës, invece, parla di estensione della psicoanalisi a dispositivi diversi da quello della cura individuale e prende in considerazione le estensioni del campo della pratica psicoanalitica. Il riferimento di René Kaës è a “dispositivi che riuniscono più soggetti” e al riguardo riporta l’esempio di “gruppi, coppie, famiglie che mettono al lavoro uno o più psicoanalisti”. “Le implicazioni e le conseguenze di questi dispositivi interessano …. il fondamento epistemologico, il metodo e la metapsicologia della psicoanalisi”. Le citazioni sono tratte da: Ferro A. (2017) “Pensieri di uno psicoanalista irriverente. Guida per analisti e pazienti curiosi”. Milano: Raffaello Cortina, 2017, e da Kaës R. (2015) “L’estensione della psicoanalisi. Per una metapsicologia di terzo tipo”. Milano: Franco Angeli, 2016.
(a cura dei coordinatori dei Seminari Internazionali)